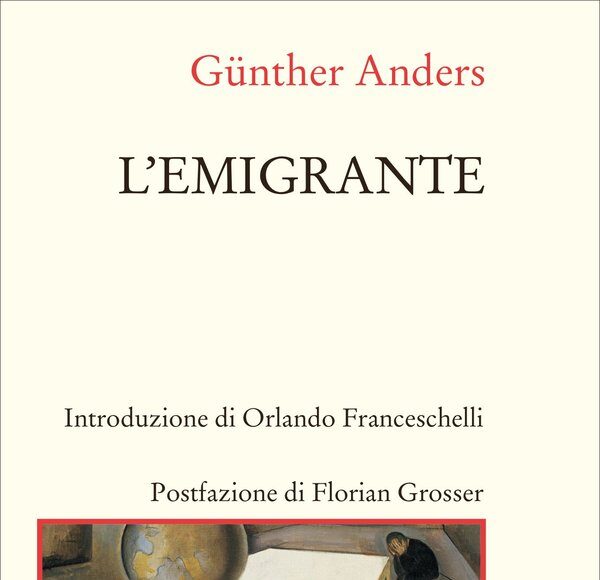Gli incontri letterari che Sociale.it propone da alcuni mesi e che hanno il titolo di “Anabasis” vogliono partire dal passato per comprendere il presente e immaginare il futuro, per creare mappe concettuali che permettano di orientarci nel nostro quotidiano individuale, collettivo e globale, per contribuire a costruire, attraverso azioni positive nutrite dalla consapevolezza, nuovi concetti per affrontare le opportunità e i rischi che il futuro può offrirci.
Particolarmente interessante è stato l’incontro attorno al libro di Günther Anders “L’emigrante” che ha avuto come ospite il curatore, il filosofo Orlando Franceschelli di cui invitiamo a cliccare per ascoltare l’intervento
Da circa 10 anni a Roma, dopo gli studi e il dottorato di ricerca in sociologia urbana a “La Sapienza” Università di Roma con il sociologo che per primo andò a interrogare e incontrare tra il fango chi viveva nelle baracche della sterminata periferia romana – Franco Ferrarotti – decisi di fondare una associazione culturale che avesse come scopo e valore quello di far conoscere genesi problemi e opportunità delle borgate o dei percorsi “non turistici”. La chiamai Ottavo Colle, il colle che pochi raccontano, quello non attraversato dal turismo di massa come gli altri sette e trascurato anche dagli amanti dell’archeologia perché ingenuamente si crede che l’impero romano abbia concentrato la costruzione di quelle che oggi sono le sue vestigia, nel “centro storico”. Per smentire questa visione basti citare per tutti la bellezza del Parco degli Acquedotti, che si trova piuttosto lontano dal cosiddetto tridente. Anni dopo ho ritrovato nella lettura dell’enciclica Laudato sì’ quella sollecitazione alla gestione di progetti di conservazione e valorizzazione di beni della collettività come il paesaggio, la piazza, i monumenti ecc. per mantenere e sviluppare relazioni e nuovi legami sociali che costituì parte di quelle riflessioni che avevano mosso il mio impegno nella formazione alla città.
Tanti sono stati successivamente i progetti e interventi formativi nei quali siamo stati coinvolti. Se ci soffermiamo a riflettere, nei programmi formativi è assente una pedagogia della città: nessuno ci insegna ad educare quegli “occhi sulla strada” che Jane Jacobs nel saggio che ha ispirato migliaia di urbanisti “Vita e morte delle grandi metropoli americane” (1961) legge e propone non in una ottica securitaria di controllo sociale, ma come un addestramento ad innamorarci delle vie, delle piazze, degli arredi urbani per rispettarli come traiettorie fisiche di relazione e-di conseguenza-a curare le relazioni di vicinato. Nessuno o pochi illuminati docenti, insegna ai ragazzi a leggere criticamente come i media rappresentano i quartieri e il grande ruolo e responsabilità che hanno nell’attribuire stigma e pregiudizi che rimarranno incollati ad essi a scapito anche di evidenze lapalissiane. Nel mondo globalizzato che ormai subiamo, è necessario partire dal legame affettivo e dalle emozioni che legano i luoghi ai loro abitanti. LO SPAZIO URBANO è sociale perché è o dovrebbe essere fonte di interazioni umane, ma è tale anche in senso negativo e deformato.COSÌ L’INCONSCIO SOCIALE si materializza nel tessuto della città, in «trasformazioni transitorie che spesso creano vuoti urbani che sono al contempo vuoti di cittadinanza e di cancellazione dello spazio pubblico»L’ARTICOLAZIONE dello spazio è un’espressione materiale e linguistica dell’inconscio sociale, che ancor prima di enunciarsi in teorie sociologiche e urbanistiche influenza il modo di intendere la strada come luogo di separazione o di comunicazione, il centro come ambiente di intesa o piuttosto – come oggi sta diventando – area speculativa, gentrificata e separata dalle periferie.
I paesaggi non sono infatti oggetto di misurazione o di definizione univoca, ma legati alla descrizione (soggettiva) e alla narrazione.
Scriveva Lowenthal in “Geography, experience and imagination: towards a geographical epistemology”:
“I luoghi nei quali viviamo, quelli che visitiamo e attraverso cui viaggiamo, i mondi di cui leggiamo e che vediamo in opere d’arte, e i regni dell’immaginazione e della fantasia, tutto ciò contribuisce alle nostre immagini della natura e dell’uomo. Tutti i tipi di esperienza da quelli legati più strettamente al nostro mondo quotidiano a quelli che sembrano spinti più lontano, si uniscono per creare la nostra immagine individuale della realtà.”
Negli anni Settanta si approda con Yi-Fu Tuan al concetto di topofilia ossia l’indagine del legame profondo fra le persone e i luoghi.
Oggi parliamo di topofilia: il rapporto di profondo attaccamento che lega le persone ai luoghi. La parola deriva dal greco tópos che significa luogo e philía, amore. E tutti l’abbiamo sperimentata perché è proprio dalla topofilia che nasce il senso di appartenenza. A una città. A un quartiere. Persino ai colori di un paesaggio. L’amore per un luogo, infatti, fa sì che questi entri nel nostro immaginario, nella sfera emotiva e spirituale. Che sia sedimento della memoria e perno della nostra identità profonda. Come la casa che abbiamo abitato da bambini, la strada in cui giocavamo fino a tarda sera, la spiaggia delle nostre vacanze o la meta di un viaggio che abbiamo sognato e mai realizzato. Una topografia privata, insomma, che abita nella nostra interiorità.
Il geografo cinese Yi-Fu Tuan ha fatto della topofilia il concetto alla base della sua riflessione che studia il territorio non da un punto di vista quantitativo e matematico, ma dal punto di vista soggettivo. Come lo percepiamo? Quali sono le nostre proiezioni su di esso? Quali sentimenti ci muove? Quali significati gli attribuiamo?Agli antipodi della topofilia si colloca invece la topofobia, ossia il senso di estraneità, diffidenza o repulsione nei confronti di un luogo. Al centro dell’interesse resta comunque l’uomo e la sua percezione. Quale può essere il paesaggio per un MIGRANTE? Il vocabolo bàrbaro (dal lat. barbărus, gr. βάρβαρος) o lo straniero, nel senso in cui i Greci e i Romani dicevano barbaro chiunque non fosse greco o romano, e nel senso in cui il Rinascimento opponeva il concetto di barbaro a quello della romanità e della classicità.Nel greco diventa barbaros, “che balbetta”, “che parla in modo incomprensibile”, “straniero”.
In latino diventa balbus . “balbuziente, e barbarus, “straniero.
Interessante il capitolo del libro dedicato alla “balbuzie” del migrante, alla ricerca incessante di una lingua nuova e di una lingua di origine che probabilmente lo accompagnerà sempre.